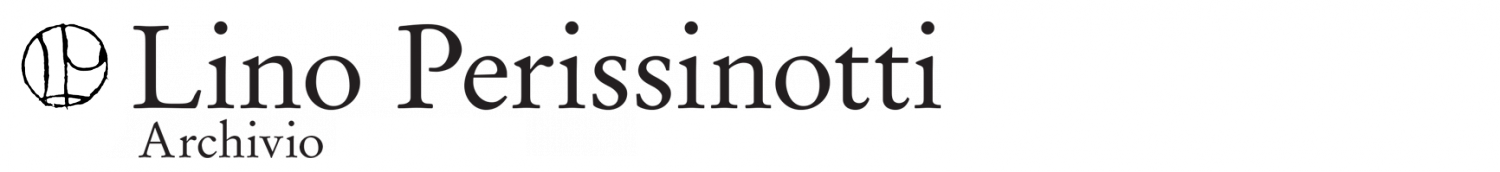Gianfranco Bruno
La prima attività significativa di Perissinotti risale agli anni immediatamente successivi alla grande guerra. Ma già nel 1913 è documentata la severa attitudine compositiva dell’artista e una scelta tematica, che resterà fondamentale, di luoghi dimessi del paesaggio. Si tratta di un piccolo quadro di casa e alberi, dove nell’impianto un po’ rigido sulle verticali a piombo filtrano tenerezze di colore nei rosa, verdi, bianchi delicati. E segni leggeri, i fili contro il cielo chiaro, annunciano quella sensibile grafia che costituirà uno degli elementi significativi dello stile maturo dell’artista.
L’esperienza diretta della grande guerra non resterà senza significato per il lavoro del pittore. Incline a interpretare la vicenda collettiva del paese nel doloroso risvolto che riguarda il dramma delle classi popolari, alle quali egli si sentiva per elettiva affinità e per scelta politica legato, Perissinotti orienterà le sue scelte negli anni ‘20 tra un simbolismo a sfondo moralistico e umanitario e una decisa attitudine realistica intesa, nei quadri di maggiore impegno, a superare il dato sociale contingente nella individuazione di valori di elevata umanità. Sebbene sia estremamente difficile indicare precisi riferimenti culturali per un artista isolato per elezione e tuttavia partecipe, in relazione ai suoi frequenti spostamenti tra il Veneto e Roma, di situazioni nelle quali confluiscono i molteplici aspetti della complessa cultura italiana di quegli anni, è possibile valutare, attraverso l’analisi dei temi della sua pittura e del suo linguaggio pittorico, un non generico riferimento al Segantini, e più generalmente a quell’umanitarismo socialista che caratterizza l’area divisionista fino alla “sintesi realistica, al limite sociologica e comunque schiettamente di classe del Quarto Stato” di Pellizza. Un dipinto del 1920, Il mattoniere, e una serie di disegni degli stessi anni, aventi come tema i lavoratori, altri disegni ancora nei quali l’artista, tra il ’19 e il ‘20, ritrae umile gente della strada, indicano l’ispirazione di chiara matrice socialista sulla quale è fondata la volontà del pittore di porsi come l’interprete della dignità e del valore del mondo operaio e contadino […].
Si può comprendere come a Perissinotti, estraneo agli ambienti culturali più avvertiti e isolato, sfuggisse inizialmente la cognizione del significato restrittivo della poetica del Novecento e mancasse soprattutto l’informazione sulla modernità. È comunque da sottolineare come l’originaria matrice di tipo socialista abbia indirizzato Perissinotti negli anni ’30, quando la tematica “popolare” del lavoro operaio e contadino viene rozzamente strumentalizzata dall’iconografia littoria, verso un abbandono dei soggetti di figura e verso una scelta di dimessi motivi di paesaggio. Ciò appare tanto più singolare se si consideri che Perissinotti, dieci anni più vecchio degli artisti della “Scuola romana” e coetaneo dei maestri novecentisti, viene a trovarsi su posizioni parallele a quelle dei giovani artisti di opposizione al Novecento. L’opposizione si verifica questa volta in una militanza, come è dato di rilevare dai dati biografici, e, sul piano dell’arte, in un’adesione “di sentimento” ai motivi esclusi dalla retorica dell’arte di regime: paesaggi di periferia, squarci di piccole fabbriche e cortili, la Roma che scompare […].
Il venetismo di elezione avvia direttamente l’artista all’incontro con Cézanne. Se inizialmente la predilezione per Cézanne deriva genericamente dall’essere il maestro pittore di colore e di paesaggio, presto la lezione cézanniana appare assimilata in quanto essa ha di più sostanziale. Le opere degli anni ‘30 documentano l’avvenuta assimilazione del processo di crescita dell’immagine cézanniana, e dell’ottica di percezione del maestro. Mi riferisco in particolare alla Natura morta con bottiglia e brocca, del 1935 […].A questa natura morta, che ritengo esempio tra i più significativi di lettura di Cézanne data in Italia nel novecento, si affianca il dipinto Attesa, del 1934.
(…) Nel 1926 l’artista è costretto a lasciare l’insegnamento perché sospettato di antifascismo: si sposta da Ferrara nel Veneto, poi a Roma nel 1933, dove resterà fino al 1936. Negli anni romani Perissinotti dipinge una serie di opere che insieme ai dipinti di Mafai e di Pirandello restano l’interpretazione più risentita e umanamente vissuta del volto vero di una città altrimenti decantata nei suoi fittizi fasti imperiali dalla retorica fascista […].
Nel 1936 l’artista si trasferisce in Liguria. Il tonalismo delle opere romane si innesta felicemente su di una immagine di paesaggio che trova in un’ulteriore riflessione su Cézanne il momento risolutore per una visione stabilizzata intorno a pochi elementi linguistici costanti. Lo stesso riporto della ricca gamma cromatica delle opere romane ad un’organizzazione del tono in cui prevalgono – soprattutto intorno al ‘50 come poi, in diversa accezione, dopo il ‘60 – toni di azzurro e di grigio, documenta la rigorosa mediazione dell’approccio cézanniano al paesaggio e la volontà di estrarre alcuni elementi essenziali all’articolazione del quadro. La Natura morta con frutta è un testo molto significativo in questo senso. (..). L’adesione a Cézanne è messa a frutto per ottenere un senso di apparizione, di nascita degli oggetti nel comporsi dei piani di colore. Presto Perissinotti trae partito da una nuova attenta lettura di Cézanne – in particolare dei paesaggi della piana prospicientela Sainte Victoire, ad orizzonte lontano sul quale si erge la montagna – per costruirsi una sua ottica sul paesaggio ligure.
La serrata trama spaziale del maestro è ricondotta a un più modesto paesaggismo di piane, colli, case di campagna, nella stesura larga dei toni il segno incide tralci, rami, profili di oggetti: la trama di un’anima attenta a ben segrete emozioni.
(…) Perissinotti ha subito la chiusura d’un ambiente ligure non solo defilato dal dibattito culturale italiano, ma oppresso da una pseudocultura provinciale. Alla vicenda ligure di una pittura del Novecento che è stata da una critica miope eretta a scuola, mentre in Liguria si hanno al più pochi nomi di autentici artisti che hanno pagato con l’esodo e con l’isolamento la loro autenticità, Perissinotti deliberatamente non ha mai partecipato. La sua pittura dopo il ’40 può dirsi “ligure” nel senso di un’adesione ad un preciso paesaggio, per la felice interpretazione di una luce che ha una singolarità e persino una sua tradizione culturale nella poesia e nella pittura […].
Nell’attività dell’artista particolare rilievo assumono i dipinti degli ultimi anni, dopo il ‘57. Qui il sentimento di natura muta in una sensibilità, nuova e antica insieme, per una visione che astragga dalle immediate apparenze immagini tenute nel silenzio degli accordi del tono. In queste opere veramente Perissinotti supera ogni pur valido paesismo in una pittura che, basata su pochi toni “di posizione”, dilata sensibilmente la qualità mentale dell’immagine […]. Perissinotti tocca così, nell’estrema riduzione d’una pittura che ha affrontato sia la densità di paesaggi e di culture di colore quali la veneta e romana sia la sfuggente diffusione della luce ligure, una dimensione espressiva che per il suo porsi come pittura di condizione non può non apparirci decisamente partecipe del nostro difficile tempo».
da Perissinotti 1913-1967, in Perissinotti, dipinti e disegni 1913-1967, Accademia Ligustica di Belle Arti, catalogo della mostra, Genova 1977.
Vittorio Fagone
(…) Dal 1915 al 1935 la lezione di Cézanne resta un termine di confronto, e certo non regressivo, per quella pittura italiana che cerca di non allontanarsi dal campo del quadro verso una greve e magniloquente celebrazione di un’Italia di gesso, dipinta con scure ocre terrose.
Questa digressione non poteva essere evitata per collocare in uno spazio reale l’opera di Lino Perissinotti. Egli vive il suo tempo con una vigilante, e solo apparente, distanza e alla riflessione cézanniana dà un contributo originale: emblematicamente egli dispone in un suo quadro una natura morta sotto la stampa di un paesaggio di Cézanne. E sono gli anni della guerra, difficili, vissuti in solitudine, nella incertezza di una referenza di attualità. Ma per almeno quindici anni il polo di riferimento di Perissinotti non ha avuto oscillazioni. E, come per alcuni altri pittori della sua generazione, questa scelta era una scelta verso la moralità del far pittura, dell’essere pittore.
Della vicenda biografica di Lino Perissinotti i soli dati vistosi che possono essere indicati sono i trasferimenti: nell’Italia dei primi decenni di questo secolo, cambiare città poteva significare non solo cambiare cielo e paesaggio, ma contesto culturale, clima espressivo.
Perissinotti, che è nato a Oderzo nel 1897 e che è vissuto a Piazzola sul Brenta sino al 1915, arriva a Bologna in quell’anno per diplomarvisi. Subito dopo, giovanissimo, è a Padova come insegnante, e tra Verona e Vicenza vive sino al 1923. Dal ’23 al ’26 è a Ferrara; qui è costretto a lasciare l’insegnamento per motivi politici: rifiuta di iscriversi al partito fascista. Torna a Piazzola a dipingere e dopo qualche anno è a Roma: vi si stabilisce definitivamente nel 1933 (tiene una mostra a Palazzo Doria). Nel ’36 è in Liguria dove torna a insegnare e vivrà sino alla fine la sua appartata giornata di «pittore nel paesaggio»: prima a Lavagna, nel periodo della sfollamento a Monticelli, dal 1952 a Chiavari.
Una biografia spoglia, chiusa dentro il confine di una calda vita familiare, in una distanza critica dalle polemiche e dagli intrighi dell’arte italiana negli anni del fascismo, punteggiata da numerose presenze nelle più importanti esposizioni nazionali (dalla Biennale di Venezia alle grandi mostre di Arte Sacra di Padova dei primi anni Trenta, quelle che scatenano la tremenda polemica di Persico contro 0ietti («la sibilla cieca») — e Persico cita anche, con Paulucci, Perissinotti — alla Quadriennale), impegnata in un lavoro di pittore, quasi sempre condotto en plein air, con un’aderenza al paesaggio che è comprensione del momento e costruzione di una forma visibile, identificazione di realtà. Il ritratto di Perissinotti pittore, per chi non lo ha conosciuto di persona, è legato a questo modo austero e vivo di essere nel quadro, all’assenza di ridondanze e di effusioni, al vigoroso muovere nel colore una scomposizione-ricomposizione come per suoni ben distinti, epperò dentro sempre una misura tonale, senza stridii, sbavature. I quadri di Perissinotti vanno letti nel loro tempo: vi acquistano senso e carica reattiva, aderenze e lontane consonanze: ma sono stati realizzati anche secondo una misura più ampia: una diretta testimonianza di esistenza, una riflessione sulla vita e sulle cose, metafore dense del quotidiano, senza artificio. Nella distanza che il tempo vi ha depositato, queste opere parlano di un mestiere esercitato con sicura coscienza, con sensibilità e concentrazione: mediazioni sull’apparenza e l’essenza del naturale, pratica dell’antica sapienza artigiana del pittore.
Perissinotti questo mestiere l’ha imparato da sé. Sembra che sul suo avvio di pittore abbia influito un giudizio positivo di Ettore Tito, un pittore che sappiamo di quale venerazione fosse circondato nel Veneto già negli anni Dieci-Venti. C’è, conservata, di quei primi anni una fìtta serie di studi e di prove: essi dimostrano piuttosto una disposizione naturale straordinaria e una pari applicazione. Sono prove rigorosamente disciplinate, esercizi di un autonomo e paziente apprendistato, ma appartengono alla sua preistoria di artista. Le prime prove indicative sono figure e scene dove l’esperienza del mondo di lavoro delle fornaci di Piazzola viene quasi trasfigurata. Il Cristo che Perissinotti dipinge è il «Cristo dei lavoratori» ricavato dalla iconografia popolare socialista dei primi decenni del secolo. Egli cioè non indulge al patetismo, al misticismo degli altri pittori suoi coetanei e della stessa zona che si mossero alla pittura su un percorso libero e autonomo: Garbari, Panchieri, Di Terlizzi, pittori sapienti e ingenui, chiusi dentro una visione del mondo religiosa, se non addirittura francescana, essi pretesero di muovere una pittura «incantata», che scopriva nella natura simboli religiosi e la ammantava di colori celestiali.
Le prime figure di Perissinotti hanno sfondi e luci venete, ma di una intensità più antica e remota. L’influenza di certi severi modelli classici (e anche novecentistici) è evidente; ma nella stessa misura vi è l’adesione a un mondo autenticamente contadino: il suo guardare all’uomo che lavora, all’uomo di fornace e di campagna, (si veda «L’uomo con la falce» del 1932), non è da una distanza estranea. E da qui la naturalezza espressiva, la plastica realtà delle immagini di vita.
Il momento forse più interessante della pittura di Perissinotti, certo decisivo, matura nei primi anni Trenta, attorno al ’33 – ’35.
Perissinotti è a Roma con una affinata coscienza di pittore, con una ormai matura capacità di rendere tensioni e senso dell’ambiente naturale dentro un’immagine costruita puntando sugli elementi strutturali essenziali, caricandone l’atmosfera dal vivo del tessuto pittorico. E Roma in quegli anni significa Donghi, Socrate, Trombadori, Francalancia, Guidi, Broglio, la loro veduta «purista» geometricamente scandita, spesso patetica e affabile, significa la Raphael, Mafai, Scipione, gli altri giovani che s’avviano a consumare gli ardori di una trasposizione barocca dell’espressionismo in una chiave moderna, reattiva. Perissinotti dimostra di aver conosciuto gli uni e gli altri, di averne studiato con intelligenza, senza subirne paralizzanti influenze, procedure e intenzioni creative. Perissinotti sente di dover dipingere Roma, come Mafai, prima che gli sventramenti la consegnino afl’effìmera apoteosi dell’Impero. Alla Biennale di Venezia del ’36 egli presenta una «Roma che scompare» (1934) che con tutta probabilità è la stessa delle «Demolizioni» di Mafai del 1936, ormai squarciata, denudata nelle tinte delle camere sospese. Negli stessi anni Perissinotti dipinge certi angoli remoti della periferia romana, certi paesaggi «fuori porta» di intensa e controllata vibrazione, dove la luce è sapientemente dosata, colta nella pienezza meridiana (Il «viadotto romano» del 1935, della Galleria d’arte moderna di Latina) e il quadro è costruito secondo una veduta che lo svolge linearmente in una progressione di piani, che ne estende il campo d’attenzione oltre i margini, dove la prospettiva s’annoda. Lo splendido «Paesaggio» del 1934 della Galleria Pitti di Firenze può mostrare con quanta sapienza Perissinotti legasse piani e superfici, ritmi verticali, fughe oblique dentro una visione vigile, compatta, continua, struttura di realtà e di percezione. Il momento romano è certo il più interessante dell’arco di produzione di Perissinotti proprio per la messa a fuoco di una propria ottica che legge certo l’esperienza di Cézanne, ma la confronta con quella dei contemporanei prossimi e distanti. Da qui si può dire nasce una scelta orgogliosa, decisiva. Le splendide «nature morte» che Perissinotti aveva dipinto agli inizi degli anni Trenta, caricando la pittura di umori densi e acri, immettendole in uno spazio di risonanza non fragile, corposamente vivo, cedono il passo a una pittura fatta «nell’aria» e costruita nel rigore. Nella lucida qualità ottica, la natura immobile è vissuta come trattenuta dalla visione, oggetto e modello di conoscenza.
Perissinotti arriva in Liguria nel 1936. Per un pittore trovarsi in questo punto della geografia della luce mediterranea ha un senso particolare. In nessun luogo d’Italia, il paesaggio è – si – può azzardare – paesaggio come in Liguria, perchè in nessun luogo la trascorrenza della luce vi gioca con tale grandioso impeto. Chi ha vissuto tra Sestri e San Fruttuoso sa che l’azzurra, dilagante liquidità di Merello è nell’aria, occupa pienamente certe ore, ogni spazio; sa la luce ebbra di certi tramonti dorati, lo splendore delle mattine di Rayper, il grigio opalescente, al confine delle vallate, che incantava Firpo. Nella nitidezza della luce ligure un pittore può ogni giorno credere di scoprire il mondo. E il mondo varia nella luce ogni giorno mille volte come una vita. Basta guardarlo, saperlo guardare, da una finestra, da un poggiolo. Per trenta anni Perissinotti ha vissuto questo paesaggio. Ha dipinto i cieli densi sopra Lavagna e Chiavari, il mare tra le rocce (ma a una distanza che lo riportasse a geometria), e più spesso ha trascritto il fitto ordito di quella geometria vivente che si stende alle spalle del mare, le ordinate vallate liguri, dove il paesaggio è realmente un «palinsesto di storia» senza nomi, dove non si cammina ma si penetra, come in una foresta che la visione dilata e moltiplica. Conosco a memoria i luoghi che Perissinotti ha guardato, e li scopro nei suoi quadri come realtà dense, come esercizi di conquista di una conoscenza che punta alla radice delle cose, della sensazione. Essere pittore in questo modo, si sa, è un grosso azzardo: ma forse per chi ha vissuto una vita interamente come vita di pittore non è neppure una scelta, è un destino da realizzare senza incertezze, senza fughe. Perissinotti dipinge le cose che gli stanno di fronte; e se l’immagine si fa essenziale, la furia con cui si addensa è sempre la stessa, come un moto insopprimibile, una ragione di vita.
da Lino Perissinotti, in Perissinotti dipinti e disegni 1913-1967, catalogo della mostra, Accademia Ligustica, Genova 1977
Luigi Carluccio
Lino Perissinotti è uno di quei pittori dei quali non si è parlato molto e sui quali rischia sempre di tornare il silenzio, perché non sono mai stati alla moda.
Per età Perissinotti appartiene alla generazione che in Italia è stata coinvolta e compromessa dalla poetica del cosiddetto Novecento, che in tutta Europa ha risposto a un “richiamo all’ordine” che doveva correggere le stravaganze delle avanguardie principio di secolo e riparare gli orrori e gli errori della prima guerra mondiale.
Intorno al 1920 la visione del mondo torna a essere fondamentalmente realistica, le cose riprendono la loro unità di struttura e di forma, il loro contorno riprende il suo posto giusto nello spazio. Perissinotti rispecchia molto bene questa situazione, proprio perché agisce fuori da ogni polemica, con la semplicità di un atto di fede nella verità delle cose amate anche per la loro terrena appartenenza.
Il momento centrale e catalizzante delle sue esperienze coincide con l’incontro con l’arte di Cézanne e gli consente quindi di rimanere fuori dalle avanguardie ma attraversandole sino a toccarne l’elemento di fondo, che è la ricerca dell’immagine espressiva attraverso l’immagine razionale.
Sensibile agli impulsi del luogo e del momento la pittura di Lino Perissinotti si modula variamente pur nello sviluppo lineare del suo crescendo. Scopre di volta in volta le suggestioni del natio Veneto, di Roma (la stessa Roma delle demolizioni e delle rovine guardata con tanta malinconia da Mafai), infine la Liguria. Suggestioni diverse – secondo i tempi di una vita piuttosto agitata da traslochi che sovente sono fughe – ma sempre illuminate da un nitido rifiuto della retorica e più avanti negli anni anche dal rifiuto della figura umana, in quanto residuo di un vago simbolismo umanitario che non ha più rispondenza nella realtà.
Così a poco a poco la pittura di Perissinotti lascia cadere tutte le sue scorie, si decanta diventa pura materia attraversata, più che toccata dalla luce, come si vede nei patetici dipinti degli ultimi anni, quando realizza Golfo Tigullio e Case sul mare.
“Panorama”, 21 giugno 1977
Giorgio Mascherpa
(…) prima d’addentrarci in problemi classificatori sarà bene cercare di individuare le “basi” linguistiche di questo appartato ma al tempo stesso “presentissimo” (dico alle vicende artistiche che gli furono contemporanee) pittore.
Nato nel Trevigiano (Oderzo, 1897), ci aspetteremmo di scoprire nei suoi primi dipinti, fondamenti spiccatamente
veneti tra il primo e secondo decennio del secolo, sia che scegliesse il colorismo e il bozzettismo intensi e sensuali dei seguaci di Favretto e dei Ciardi, sia che seguisse la nuova, fresca e spesso straordinaria verve secessionistica-espressio- nistica degli artisti di Cà Pesaro, Gino Rossi, Tullio Garbari, Arturo Martini etc.
Ebbène è quanto mai significativo che, oltre ad una nativa propensione perissinottiana al colore limpido e caldo e tonale, altro di veneto non ci sia nei suoi primi quadri, nè di sapore tradizionale nè avanguardistico. Se qualcosa invece rammentano le primissime opere del pittore attorno al 1918 e seguenti, son quadri d’ambito bolognese e romano, dico l’opera di bolognesi (nella città emiliana s’era diplomato in belle arti…) come il Pizzirani o Giovanni Romagnoli e sopratutto come il “non-allineato” Carlo Corsi, cui riportano direttamente quei controluce spinti fin dentro il sugo della materia, venati d’intimismo e insieme di naturalismo, figure e ambienti accesi come da un interno fuoco.
Lo sviluppo immediatamente successivo e la pittura di figura che ne scaturì, tradiscono invece l’esperienza romana che Perissinotti compì negli anni trenta: echi di Spadini e quel singolare modo di rileggere Cézanne in panni realistici e di racconto che caratterizzavano il miglior momento di un Soffici o le esperienze giovanili di un Virgilio Guidi.
Il suo “realismo” iniziale è giusto quello di chi vuole (o sogna) imprimere ad una pittura feriale, quotidiana, una sua interna monumentalità. Basta meditare su dipinti come “Siesta” (1929) o “La cena di Emmaus” (1931) per avvedersene, una sorta di dialogo che si instaura tra le figure e ne escono battute talmente vere che il lettore stesso può immaginarvi il suono. L’impostazione è tipicamente novecentesca ma affatto novecentista e cioè appare aliena da impostazioni astratto-statuarie e sembra invece far capo ad una pittura che blocca gesti reali in un istante di straordinaria durata temporale. Che poi questo realismo, che porta Perissinotti a dipingere oltre la natura, contadini e operai (il mondo da cui veniva) in chiave di severa bellezza tuttora ispirata al “socialismo umanitario” di Pellizza e di Morbelli, mutasse indirizzo dopo il ’30, oltreché per le vicende non certamente serene della biografia dell’artista, significa, a mio avviso, una presa di coscienza del proprio limite e della propria dignità umano-artistica che altri, anche insigni protagonisti del nostro tempo (e valga per tutti, Morandi), assunsero definitivamente proprio su quel “fatal crinale” degli anni trenta e fu, con tutte le varianti d’artista, una presa di possesso della natura severamente, quasi ostinatamente sul vero, una sorta di rilettura, alla luce delle avanguardie passate e presenti, del gran fatto della pittura.
Misurando, come fece, tra il trenta e il quaranta, il paesaggio italiano (da Roma a Bologna, dall’Umbria alla Liguria con soventi intermezzi veneto-friulani), Perissinotti ascrisse dunque alla sua conoscenza una sorta di rilettura della sua terra ripercorrendone i contorni così svariati e splendidi e, al tempo stesso, verificandone la realizzazione pittorica alla luce delle istanze più sottilmente attuali. Dove il “sottilmente” sta ad indicare che esse non furono di carattere avanguardistico e cioè evidenziate sul piano formale ma interne, consustanziali alla forma e alla pittura alludendo dunque ad un realismo-espressionismo paesaggistico da un lato e ad una marcata accentuazione oggettiva dall’altro. Tutti fenomeni, del resto, come i recenti studi hanno chiarito definitivamente, di portata internazionale, a partire dalla “nuova oggettività” tedesca per giungere a quella americana, come la mostra dei “realismi” ha rivelato.
In Perissinotti ciò non avviene senza opposte tentazioni o, se vogliamo meglio, analisi. Una pittura per nitida fino all’oggettività pervade con nitori di cristallo le sue bellissime “nature morte” (“fiordalisi”, “Fiori secchi”, con accentuazione dopo il ‘45); l’altra, s’avvicenda a questa nel definire paesaggi «love luci misteriose introducono una sorta di metafisica attesa (“Paesaggio padovano”,1932, “S. Onofrio”, ecc.). Entrambe caratterizzate, si intende. e percorse, dalla spontaneità di Perissinotti, così incline alla limpidezza pittorica e alla commossa verifica oggettiva delle emozioni, e voglio dire che un giallo. un rosa, un azzurro si compongono nel quadro sempre come se fossero “veri” cioè ispirati soltanto alla realtà anche quando sono invece palesemente accordi cromatici indispensabili al tessuto del quadro.
Che in tali condizioni Perissinotti risentisse qui l’eco (…) di chi più saldamente gli operava accanto nella sua stessa direzione è documento inoppugnabile della sua umiltà d’artista (…) in cerca continua di verifica, di comparazione, di accrescimento di spessore e di intelligenza critica. Cosi’ la sua “verifica” romana delle luci e delle tonalità, con l’assunzione di quella luce bipolare che è tipica di Roma e dei suoi pittori da sempre e, in particolare, su quel fortunato crinale che sta tra il venti e il quaranta. Dove la prima polarità è quella argentea, incredibilmente fonda, poussiniana (e quindi spadiniana e poi pirandelliana) e l’altra invece è dorata, calda, sensuale ed è materia prima soprattutto della “scuola romana” in senso lato, dico non soltanto i furori barocchi/espressionistici del grande Scipione o di Mafai, ma anche la patina calda dei vari Francalancia e Cesetti. Senza contare, s’intende, che a Roma, in quel “fatai” biennio 1932-34 che doveva contribuire a maturare e ad evolvere la sua pittura, Perissinotti rincontrò più a lungo il suo prossimo, prediletto compagno di pittura degli ultimi decenni liguri, dico quell’Alberto Salietti che, partito sul tronco novecentista, stava sviluppando una sua oggettività luminosa e architettonicamente maestosa proprio nella molteplicità dei dettagli, operando cioè all’opposto delle sintesi squadrate dei compagni di cordata sarfattiani.
L’incontro con Salietti significava d’altronde anche una più larga e variata conoscenza di un ambito culturale così significativo in quei decenni e in un secolo qual era quello milanese e, in particolare, di un grande pittore che, del resto, prediligeva, tra le sue contemplazioni lacustri-serianesi, frequenti pause marine, Arturo Tosi.
(…) Nell’immadiato dopoguerra e negli anni seguenti (…) Perissinotti ha meditato sugli esempi e sui modelli decisivi della sua formazione artistica, e quanto costante fu, ad esempio, la sua rilettura cézanniana, lo dicono proprio certe vedute liguri del sesto decennio inoltrato dove un colosso di montagna intrisa di ombre sullo sfondo è introdotto da una sorta di progressiva apertura di spazi dinnanzi, che, per via di luci soprattutto, ascendono e introducono alla vetta.
(…) La Sainte Victorie e l’essenzialità dell’ultimo Cézanne portarono anche, ovviamente, l’esperienza di Perissinotti (che fu vivace e creativa fino alla morte) ad una sempre maggiore semplicità linguistica.
I contorni si campiscono dopo il ’60 come spazi colorati; i dettagli oggettivi della narrazione divengono ombra, rilievo, impasto cromatico puro, mentre il quadro, fatto di pennellate lunghe e succose, sembra concentrarsi oltre la narrazione, nella sintesi, nella scansione essenziale e possente di uno spazio paesistico-atmosferico. Questo proprio mentre le forze appaiono lasciarlo, sicché in questi estremi dipinti sono la spontaneità e la generosità espressiva a prevalere, ribadendo una natura tormentata e tesa alla costante crescita interiore ed espressiva: un pittore “umile” dunque, ma che non chinò mai gli occhi di fronte alla vita e alle necessità espressive dell’artista.
da Perissinotti e la “sua avanguardia”, in Perissinotti olii 1924-1066, catalogo della mostra, Pinacoteca Comunale “Alberto martini”, Oderzo 1982
Giorgio Di Genova
(…) Quella delle tre Venezie, anche per la loro posizione geografica, ancora nell’immediato dopoguerra era un’arte di frontiera. Le declinazioni degli stilemi secessionisti e liberty persistevano addirittura all’interno di soluzioni impastate di postimpressionismo. Negli anni Venti l’impegno di parecchi pittori di queste regioni si rivolgerà al superamento di tali fardelli linguistici. E quel che nella città scaligera, dove nello stesso periodo il neofita futurista Amos Ernesto Tomba faceva le sue innovative proposte di scenografia e Pino Casarini andava affinando i suoi strumenti per passare dal disegno, dall’acquarello e dalla tempera alla pittura ad olio, avviene a Vitturi, Trentini, Zamboni e Farina, ma anche ad un irrequieto girovago come Lino Perissinotti, nativo di Oderzo, che, superate certe suggestioni della pittura veneta, comprese talune inflessioni della cosiddetta Scuola di Burano (Chioggia, Le Comari, 1925), approdò ad un discorso dall’ottica più definita, innervato sul mondo contadino ed operaio, quest’ultimo ispiratogli dalla situazione industriale di Piazzola sul Brenta. Con un’opera del genere, Dopo lo schianto, raffigurante un’affranta coppia di popolani seduta ai lati del tavolo, venne ammesso alla Biennale del 1926.
La figurazione di Perissinotti, dopo un fare più libero e spontaneo nella resa dei suoi soggetti per lo più con scene di lavoro (Il mattoniere, 1919 ca.), con gli anni si fa pacata per una più definita resa oggettiva, attuata tuttavia senza concessioni al novecentismo, né al Realismo Magico, nonostante certa propensione alla levigazione delle superfici (Operai, 1928 ca.; Siesta, 1929), propensione vieppiù accentuata dagli ambienti spogli e miseri, che nel clima degli anni Venti fecero apprezzare il pittore con inviti a diverse mostre nel Veneto. La resa delle figure di Perissinotti non è mai celebrativa, come avviene nei consacrati campioni del Novecento. Nella sua antiretorica, essa è piuttosto partecipativa, di una partecipazione sommessa e completamente scevra di orpelli ideologici ed idealistici, alla stregua delle ambientazioni delle sue scene. Certo traspare la scelta di :campo diversa da quella di tanti pittori che per convinzione, ma in vari casi anche per ottenere riconoscimenti e prebende, si esaltavano nella retorica del regime. Eppure ciò non impedì che i dipinti di Perissinotti della seconda metà degli anni Venti fossero «largamente: riprodotti», come osserva Franco Sborgi, che subito aggiunge: «addirittura uno, Il cieco di guerra, non fra i più significativi, del1927, è diffuso in migliaia di esemplari formato cartolina, secondo un interessamento puramente strumentale»! spiegando così tale fenomeno nei confrohti dei quadri di Perissnotti si sia potuto verificare «per la loro rispondenza ad un’interpretazione profondamente popolare della realtà», per cui divennero «facilmente strumentalizzabili nei termini del populismo d’occasione che fu spesso il fiore all’occhiello, da parte della cultura ufficiale fascista».
Chi all’epoca fu vittima dell’ubriacatura conseguente agli appelli del ritorno all’ordine volle riscontrare certi riflessi del primo Novecento nelle opere perissinottiane di questo periodo. Invece, a ben guardare, il pittore sin dal 1925, cioè poco dopo la presentazione alla XIV Biennale della mostra dei “Sei pittori del ‘900”, intese opporsi proprio alle indicazioni sarfattiane con un’opera di sottile allegoria, quale La burattinaia. Sono propenso a credere che questo dipinto, con quella donna completamente intenta a far gesticolare secondo i suoi desideri, i burattini, sia stato ispirato all’artista dal rapporto tra i pittori novecentisti e la Sarfatti, con la quale, del resto, da quanto riferito da chi conobbe l’artista, Perissinotti ebbe rapporti tutt’altro che idilliaci, com’era logico che fosse per un antifascista.
in G. Di Genova, Storia dell’Arte italiana del ‘900, generazione e maestri storici, tomo II, ed. Bora, Bologna 1994
Giuseppe Luigi Marini
Nel caso di Perissinotti, il comportamente stesso dell’autore, alieno da compromessi di sorta, di qualsivoglia opportunismo con l’arte di regime e di accondiscendenza con il mercato, l’implicita concezione di una libertà e di una spontaneità artistiche da salvaguardare ad ogni costo, l’indifferenza alle lusinghe della notorietà a prezzo di abdicare alle proprie convinzioni, le circostanze stesse di una vita sino al 1936 (l’anno del suo definitivo trasferimento in Liguria), per certi versi, raminga, ancorché sovente motivata da perseguire urgenze di aggiornamento e perfezionamento linguistici, hanno finito per complicare le tracce della sua avventura pittorica. Si è cioè conferito risalto privilegiato alla seconda parte della sua produzione artistica, in quella metà della vita che, trascorsa a Chiavari, ha progressivamente accreditato, per Perissinotti, l’assimilazione di fatto, in verità più collezionistica che critica, alla pittura “ligure”: un accidente solo topografico che contrassegna i suoi soggetti paesistici, ma che non è carattere limitativo e individuante di un’espressione a caratura regionale; come non lo è stato per un suo seguitato amico e concittadino di elezione, Alberto Salietti, e come non lo è per un altro pittore, Arturo Tosi, soggiornante a Zoagli, con il quale l’artista trevigiano fu in documentato contatto.
(…) sin dalla postuma a dieci anni dalla morte, nel giugno 1977 all’Accademia Ligustica di Genova e nel luglio dallo stesso anno presso la Cassa di Risparmio di Chiavari, ordinate da Gianfranco Bruno; e in quella successiva che, presentata da Giorgio Mascherpa nel 1982 alla Pinacoteca Comunale A. Martini di Oderzo, ha celebrato l’artista nella sua città natale, si è andato definitivamente precisando il contributo originale di un protagonista, appartato ma profondamente partecipe alla temperie culturale del proprio tempo. L’allargato contesto supera ampiamente ogni limitante etichettatura regionale (…) Anzi, i contorni e i contenuti del linguaggio di Lino Perissinotti si definiscono proprio nei poco più che tre lustri che precedono il suo definitivo approdo sulla riviera di Levante, attraverso un percorso “insolito” sin dagli esordi.
Nel proprio studio di Piazzola sul Brenta elabora una caratterizzata poetica, di decisa attitudine realistica che, pur nell’ambito di un rifiuto delle avanguardie, non si riallaccia all’ancora resistente vena vernacolare tardottocentesca (…) né ad una delle tante declinazioni degli stilemi secessionisti in auge nelle biennali veneziane d’inizio secolo (…). La sua radicazione “veneta”, semmai, si rifugia, anziché in un quasi proverbiale “colorismo”, in una coscienza di linguaggio che ha ben presenti il valore “distillato” dei toni caldi e la loro armonia nel colore limpido: quasi che, più che dai luoghi d’origine, traesse alimento dall’ambiente bolognese (da quella Bologna in cui si era diplomato), da Romagnoli, Pizzirani e Corsi, però senza concessioni e inflessioni intimistiche e crepuscolari. Ma già il soggiorno romano del 1920 (quando debuttò con la sua prima personale), deve confermarlo nella definizione di una pittura di figura attualizzata in quella chiave novecentesca (e non novecentista) che caratterizzerà, in un vasto ventaglio di esperienze, l’arte italiana tra le due guerre.
È proprio l’ambiente in cui vive, a Piazzola sul Brenta, che lo avvicina a una realtà contadina e operaia in piena crisi economico-sociale dopo il peso enorme sopportato dal Veneto durante il massacro della guerra mondiale: realtà da cui proveniva, che condivideva e che elegge a soggetto dei propri interessi di pittore “realista”, ma erede spirituale del socialismo umanitario ch’era stato di alcuni divisionisti, nell’intento di conferire nobiltà e serena bellezza ai propri personaggi e ai suoi gruppi. L’evoluzione a una più levigata resa oggettiva delle figure, negl’interni spogli della loro quotidianità, non rievoca la monumentalità perseguita dal gruppo storico di Novecento, bensì intende fermare la realtà non in astratte cristallizzazioni statuarie, ma nell’impressione di rallentata e più durevole evidenza temporale. Sebbene tali lavori, dalla metà circa degli anni venti all’inizio del quinto decennio del secolo scorso, d’intima e vera partecipazione, rifuggissero da ogni intento celebrativo “compiacente”, talvolta dalla retorica di regime vennero assimilati, opportunisticamente, e strumentalizzati nei termini del populismo fascista di occasione. A tale proposito è utile rammentare la distanza di un clima novecentesco diffuso, ch’è la tendenza figurativa predominante nel ventennio tra le due guerre, dal “richiamo all’ordine” disciplinato in più precisa formulazione dal gruppo di Novecento, organizzato e condotto per mano da Margherita Sarfatti. Anzi, per un antifascista come Perissinotti, la non gradita assimilazione in quell’ambito di esperienze fu addirittura esternata, neppur troppo cripticamente, nel 1925, cioè nell’anno successivo alla presentazione alla XIV Biennale veneziana dei “Sei pittori del ’900”, con l’olio «La burattinaia», dove nella donna che manovra a piacimento le marionette, il riferimento al rapporto tra la Sarfatti e i pittori della sua “scuderia” era oggetto di un’allegoria esplicita: come ha acutamente osservato Giorgio di Genova nella sua Storia dell’arte italiana del ‘900 (1994, p. 887). Fatto sta che Perissinotti abbandonerà progressivamente, definitivamente dopo il 1934, la figura e l’esperienza di contiguità “purista”; non gli schemi compositivi soliti e di ricupero dell’essenzialità del reale, insistendovi nel paesaggio e nella natura morta, specie in quest’ultima perseguendo un personale approfondimento dell’espressività dell’oggetto e del suo posizionamento spaziale.
Essenziale per l’evoluzione linguistica dell’artista, prima del definitivo rifugio ligure, è il trasferimento a Roma dal 1933 al 1936.
In quegli anni incontra nuovamente Alberto Salietti, che già si svincolava dal cordone ombelicale novecentista, affascinato da una oggettività luminosa e analitica. E incontra, non come compagni di avventura, ma come stimolanti presenze artistiche, gli esponenti della Scuola Romana, implicitamente condividendo il distacco da “Novecento” in termini di lirica pura del paesaggio urbano. E di un particolare paesaggio: quello dimenticato e disatteso di una Roma minore che sta per sparire sotto il piccone degl’indiscrimati interventi urbanistici intesi a sublimare l’effimera apoteosi fascista della capitale di un impero: o gli angoli senza magniloquenza, dimenticati, della periferia urbana, del fuori porta. Sempre dal vero, controllati così negli elementi che li compongono come nella luce giustamente dosata e nei colori armonizzati in una percettività di apparente immediatezza, che forse sottende un intervento interpretativo e “creativo” di composizione del quadro: senza, però, che si avverta la minima forzatura. Sono gli anni che immediatamente precedono l’ultima meta di questo artista “migratore”, che ha percorso e dipinto gran parte del paesaggio italiano; quando non imita e non “prende” da nessuno, bensì, per la sua stessa moralità, non può fare a meno di condividere istanze o assimilare ciò che è in consonanza con la coscienza, il sentire propri e possa stimolarli. Attraverso tali esperienze si consuma un approfondimento della lezione cézanniana, che supera l’iniziale semplicità di riferimento a un pittore di colori e di paesaggi, per farsi rilettura e meditazione, in un’ottica di percezione ben più rigorosa nella stessa organizzazione della visione, mai “vedutistica”, degli anni successivi: quelli liguri, appunto.
A Chiavati Perissinotti, a parte i seguitati contatti con Salietti, pare estraniarsi ancor più che in passato, rispetto a un ambiente artistico provinciale che non lo stimola e non frequenta, chiuso in una sorta di isolamento, che avrebbe potuto anche risolversi in una fase involutiva della sua pittura di paesaggio, oscillante fra lucidi intenti analitici e più sintetiche definizioni di luci e di campiture pittoriche. Si lascia guidare solo dalla propria sensibilità e il mutevole paesaggio ligure, che conosce nitori e variazioni di luce, singolarità e diversità innumeri, che lo affascinano, finisce per costituire la palestra di suggestione e di costante appropriazione espressiva di un pittore per vocazione, lontano da opportunismi e remore a manifestare il proprio approccio ad esso.
Quantunque perseguitato da una salute malferma, che ostacola e dirada il suo esercizio al cavalletto, Lino Perissinotti prosegue, sino all’estremo, la sola esperienza che conosca e ami: quell’essere pittore per scelta, per vocazione, per destino, attraverso immagini sempre più essenziali, in pennellate sempre più dilatate, allungate, sommarie, in impasti cromatici sempre più sobri e meditati, che lo riallacciano, specie nelle opere estreme, ad una fascinazione cézanniana continuamente rimeditata in autonoma rielaborazione di accenti. Sono dipinti forse meno immediatamente appaganti, rispetto ai precedenti; ma assai più interiorizzati, nei quali il riferimento al reale può anche stemperarsi in una rimeditazione, in una categoria della mente atta ad esprimere una sensazione.
É la conclusione, tutt’altro che in minore, della vita di un artista che antepose la propria coerenza e i valori dell’onestà intellettuale e della famiglia agli allettamenti distraenti di una notorietà che, pure, in certa misura gli arrise.
(…) (Artista “itinerante” per oltre la metà della vita, per vocazione e per necessità, non meno che per curiosità e tensione morale di onorare al meglio il mestiere di pittore che aveva scelto, Perissinotti merita una considerazione assai meno provinciale di quella a cui è stato per molto tempo confinato. (…) Opportunamente rassegne quali la mostra sul Novecento italiano di Milano (1983) e, tra le altre, le due genovesi appunto intitolate al Novecento in Liguria (1994 e 1995), ch’è, oviamente, altra cosa del Novecento ligure in senso stretto, hanno ricondotto la lettura storico-critica dell’artista in quel giusto contesto che gli spetta.
da Lino Perissinotti pittore del novecento, in Lino Perissinotti, catalogo mostra Galleria Berman, Torino 2004
Elena Pontiggia
La cena di Emmaus di Perissinotti, dipinta nel 1931 ed esposta alla Mostra Internazionale di Arte Sacra di Padova dello stesso anno, presenta un’iconografia insolita. Cristo non spezza il pane seduto a mensa con i discepoli, ma compare in piedi, quasi in atto di servirli, nella posizione che tradizionalmente è occupata dalla fantesca o (pensiamo a Caravaggio) dagli umili padroni di casa.
Si tratta di una forzatura ideologica riconducibile alla sensibilità pauperistica del’artista, vicino a quel socialismo umanitario che nell’arte italiana aveva avuto il suo padre ideale nel Quarto Stato di Pellizza da Volpedo. Al di là dei contenuti, peraltro, il novecentismo di Perissinotti affiora con evidenza nel senso volumetrico e plastico con cui l’artista affronta ogni particolare, conferendo peso, spessore e rilievo non solo agli oggetti (si noti la bellissima e scarna natura morta, formata dalla brocca e dalle due scodelle), ma anche alle figure, soprattutto a quella in primo piano, scolpita come una statua di marmo nel bianco del panneggio.
in Quadri per una donazione, in La bellezza della croce, Museo della Santa Casa, Loreto 2005